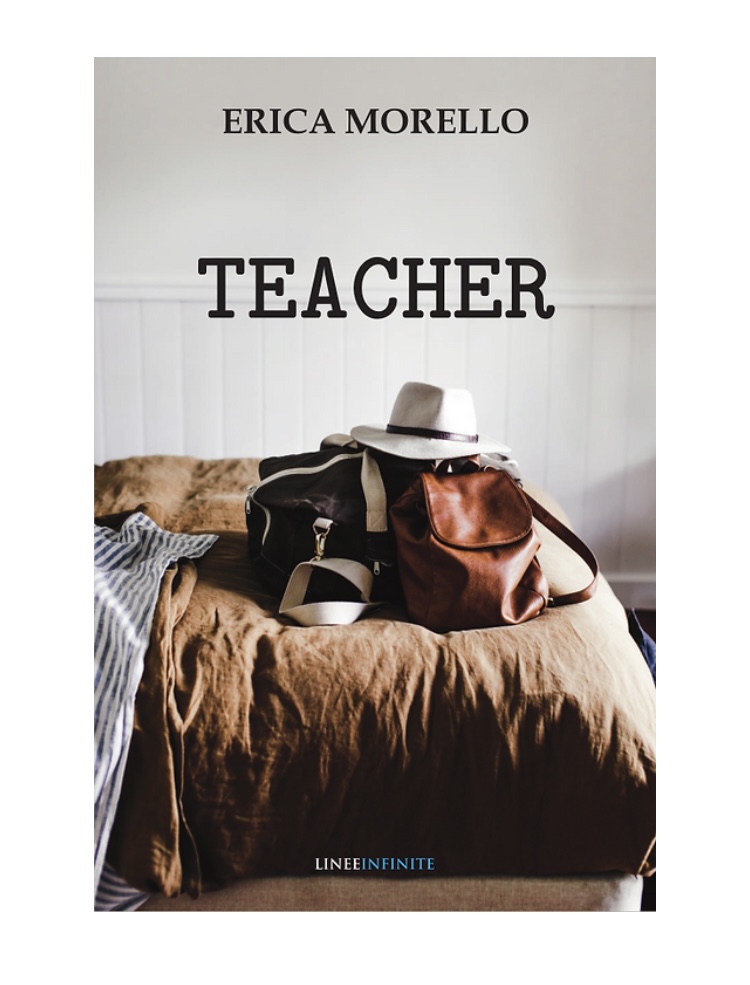CAPITOLO SECONDO
10 Luglio 2018
Mi svegliai presto.
Nonostante odiassi interrompere il sonno quando
ne avevo ancora bisogno, non mi innervosii. Dovevo fare lezione a Makiko, una dolce signora giapponese. Aveva qualche anno in più di me ma gliene avrei dati senza alcun problema dieci o quindici in meno. Il suo viso era pulito, chiarissimo, privo di imperfezioni o rughe e sempre racchiuso dentro un perfetto chignon di lucenti capelli neri.
Era molto educata. La donna più educata che aves- si conosciuto. Gentile. Sorridente. Non alzava mai la voce, nemmeno quando rideva. Le lezioni con lei era- no un toccasana, forse più per me che per lei. Mi trasmetteva una tale energia e pace che, finita l’ora, mi sentivo riappacificata con me stessa e il mio corpo. Il più delle volte faceva lezione in giardino, davanti a un piccolo laghetto circondato da piante e alberi di un verde brillante che sembrava finto. Riuscivo a sentire addirittura il rumore dell’acqua, ogni volta che uno dei pesci rossi saltava fuori.
Aveva deciso di rinfrescare il suo inglese. Più per piacere personale che per necessità. Era riuscita a raccontarmi qualcosa della sua famiglia: del suo adorato marito spagnolo che viaggiava molto per lavoro e l’aveva accontentata quando era voluta ritornare a vivere nella sua città natale; dei suoi tre figli maschi ormai grandi e tutti fuori casa per lo studio; dei suoi hobby.
Era una dottoressa. Per specializzarsi, da giovane era andata a studiare alcuni anni in America, a Miami, dove era riuscita a concludere gli studi. Lì aveva conosciuto il marito e, più che l’inglese, aveva imparato meglio lo spagnolo.
Con la nascita del primo figlio e il lavoro sempre più pressante, aveva deciso di mollare la professione tanto sudata e di occuparsi della famiglia. Si erano poi trasferiti in Giappone e, con il passare degli anni e gli impegni, aveva quasi del tutto dimenticato la lingua imparata sul suolo americano.
Mi aveva contattata per caso, attraverso un suo conoscente che era venuto a Londra e aveva fatto qualche lezione con me in preparazione di un importante colloquio.
Ormai erano anni che ci vedevamo. Una volta la settimana. Anche se mi imponevo di non affezionarmi a nessuno, non potevo negare che ogni volta era un piacere vederla e, in cuor mio, speravo non si stufasse mai di me.
Non mi capitava di pensarla così per tutti gli studenti. Alcuni entravano e uscivano dalla mia vita velocemente, come una folata di vento d’estate. Altri mi rimanevano nel cuore e nella testa per sempre. Come Ana. Anche lei aveva qualcosa che mi affascinava. Il suo modo di parlare. Di sorridere. La sua vita. Ero contenta di averla conosciuta.
Le due del pomeriggio arrivarono velocemente. Come per magia mi trovai trasportata di nuovo a Rio.
«Ma dove sei finita?» esclamai eccitata.
Ana aveva la testa in ombra che sbucava da un angolo del monitor. Il sole alto e forte appariva dietro la sua spalla. Non mi capacitavo mai che lì fosse inverno. Due piedi pieni di sabbia sbucarono sopra la sua testa. Era sdraiata per terra.
«Oggi sono venuta in spiaggia. Ti presento la famosa Ipanema.»
Alzò di poco il braccio destro in alto per indicare il paesaggio intorno a sé. Riuscii a scorgere delle persone in costume che camminavano e correvano dietro di lei, sbirciai qualche ambulante intento a vendere gelati e una bambina dalla carnagione scura che faceva la ruota sulla spiaggia. In fondo, una sottile linea azzurra mi suggerì che il mio sguardo si stava perdendo sul mare.
Mi fece venire voglia di essere lì e di potermi tuffare tra quelle acque azzurre. Non ero mai stata un’amante della tintarella, ma adoravo nuotare. Avevo preso di- versi brevetti di immersione da giovane. Adoravo sentire la pressione dell’acqua su di me. Mi faceva sentire libera. Sott’acqua, come in aria, era l’unico posto in cui riuscivo a non pensare e a sentirmi davvero me stessa.
«È bellissimo. La prossima volta voglio vedere Co- pacabana allora,» risposi scherzando. Conoscevo solo quei due posti di Rio.
Ormai mi sembrava di conoscerla da una vita. Non erano nemmeno passati due mesi dal nostro primo in- contro, ma sentivo che si era creata una bella alchimia tra di noi. Non mi succedeva con tutti i miei studenti; era un qualcosa che non si poteva costruire o forzare. C’era e basta. Non importava se ci conoscevamo da poco o se avevamo una grossa differenza di età.
Mi piaceva trascorrere del tempo con lei; non lo potevo definire un peso o un lavoro stancante. Ana stava uscendo piano piano dal suo guscio intimidito e iniziava a raccontare qualcosa in più. Ma anche i suoi silenzi dicevano tanto di lei; era un’ottima ascoltatrice e osservatrice. Con poche parole riusciva a tirarmi fuori ricordi e immagini personali, custoditi nel profondo del cuore, che non avevo mai condiviso con nessuno.
«Come mai sei andata in spiaggia? Si avvicina la partenza per la grigia Londra e inizi a provare nostalgia per la tua città? Dai, anche qui non è così male. Solo un po’ diverso.» Le feci l’occhiolino.
Ana rise di gusto prima di rispondere: «No, no, nessuna nostalgia. Non vedo l’ora di venire. Devo incontrarmi con il ragazzo dopo la lezione, qua vicino. Ho approfittato per venirci prima.»
«Brava. Hai fatto bene. Hai detto il ragazzo. Intendevi il tuo fidanzato o volevi dire un ragazzo?»
«No, no. È un ragazzo! È un ragazzino, in realtà. Un bambino. L’ho conosciuto a dei corsi che faccio in par- rocchia. Si chiama Lisandro. Arriva dalla Cidade de Deus.» Terminò la frase con uno strano sguardo.
Cidade de Deus, mi ripetei in testa. Non l’avevo mai sentita. Non sapevo cosa significasse. Ma, nel pronun- ciare il nome, il suo sguardo era cambiato. Un’ombra veloce di apprensione aveva attraversato di colpo i suoi occhi. O era stata paura?
Come se mi avesse letto nel pensiero, si affrettò a darmi la traduzione: «Significa “la Città di Dio”. An- che se, alcune volte, di Dio ha ben poco.»
«Cosa intendi?»
«È una favela. La più povera della città.»
Sembrava che, dicendo così, mi avesse spiegato tutto. Sapevo cos’era una favela, conoscevo lo stato di povertà di cui erano intessute le persone che ci vivevano. Ma non capivo il senso della mancanza di Dio, prima accennata.
«Le persone non sono religiose lì?»
Era una domanda con poco senso ma volevo capire meglio cosa volesse insinuare.
«Sì sì, qua siamo tutti molto religiosi. In apparen- za, almeno. Diciamo che nelle favelas, il Dio che viene adorato di più è il denaro. Ormai la povera gente viene sfruttata solo per fare soldi. Bambini compresi.»
Inevitabile. Come in tutte le zone povere.
Scossi la testa sconsolata per la triste realtà. «Eh, immagino. Purtroppo ogni città ha i suoi lati più brutti. La povertà e la delinquenza sono ovunque.»
«Sì, ma non così. Ne sono sicura. Le cose peggiorano di anno in anno qua. Le bande criminali che governano le baraccopoli sono passate a traffici più pericolosi. Si sono estese oltre i confini nazionali. Non si spaccia più droga solo per il Paese, ma per tutto il mondo. E sono passati a usare i bambini. Tanti di loro spariscono improvvisamente dalle loro case. La sera vanno a dormire e la mattina non ci sono più. O vengono portati via mentre sono in giro a giocare con i loro coetanei. Tanto nessuno li guarda o controlla. I maschi vengono usati per produrre ogni tipo di stupefacente, perlopiù cocaina, o arruolati in qualche attività microcriminale, e le femmine… beh ti lascio immaginare. È uno schifo, davvero.»
Ana non mi aveva mai parlato così. Non per tutto quel tempo. Non con quel tono ed espressione. Non stava mentendo. Si vedeva che quelle cose le stavano a cuore. Non ero a conoscenza di quei dettagli ma non mi stupii più di tanto. La criminalità avanzava di pari passo con la povertà e in Brasile di poveri ce n’erano molti.
Anche io da giovane mi indignavo molto davanti a quelle discriminazioni. Aiutavo chi potevo con le mie scarse risorse ma avrei dovuto fare di più. Avrei voluto che tutti facessero di più e mi arrabbiavo davanti al menefreghismo e all’indifferenza altrui.
La capivo. Cercavo le parole giuste per consolarla ma la mia maturità ed esperienza mi impedirono di mentirle e di dirle che tutto sarebbe andato bene. «Il governo fa qualcosa?»
«Il governo fa finta di non sapere niente. Nessuno sa. Nessuno parla qui. Quando le cose aumentano di volume, fanno un po’ di pulizia per nascondere il marciume e tutto ricomincia da capo. E intanto i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi.»
Era davvero dispiaciuta. Stavo per dirle qualcosa ma notai che voleva continuare a parlare.
Rimasi zitta e aspettai. Aveva voglia di sfogarsi, quel giorno. Voleva mettermi al corrente di quanto stava succedendo. Non aveva mai toccato quell’argomento prima di allora. Forse, ora che si era instaurata tra noi più fiducia, si sentiva più libera di aprirsi. Come se dovesse liberarsi da un peso che teneva dentro.
«Ormai le favelas sono piene dei meninos de rùa, i bambini di strada. La maggior parte di loro è orfana o abbandonata dalla famiglia. Sono degli scheletri che camminano e, per combattere i morsi della fame, sniffano colla. Quasi tutti diventano dei tossicodipendenti che raramente arrivano all’alba della maggiore età. È davvero sbagliato tutto ciò. Guarda, non hai idea di quanto la situazione mi faccia stare male. Vorrei andarmene via il prima possibile ma allo stesso tempo vorrei poter fare di più. È pur sempre il mio Paese. La mia città.» Sbuffò indignata e frustrata.
«Lo so, Ana. Ti capisco. Anche io alla tua età cercavo in tutti i modi di far emergere la giustizia. Sentivo come se dovessi svolgere una missione e aiutare più persone possibili. Qualcosa ho fatto. Una goccia in quei mari corrotti, ma mi piace pensare che gli oceani siano fatti da gocce e ogni gesto, seppur minimo, è importante. Già solo il fatto che ti sta così a cuore la situazione ti fa onore, davvero.»
Non sembrava convinta ma accennò un sorriso a mo’ di ringraziamento.
«Che corsi tieni ai ragazzini?»
Cercai di cambiare argomento per distrarla. In realtà mi interessava molto saperlo. Mi aveva accennato che aiutava come volontaria una parrocchia per la gestione dei ragazzi situata proprio nella Cidade. Ero curiosa di saperne di più.
«Di tutto e di più. Sono piccoli. Alcuni non hanno nemmeno dieci anni. Disegniamo. Balliamo. Suoniamo. Cantiamo. Preghiamo. Coloriamo. Leggiamo delle storie. È solo un modo per tenerli lontano dai guai, in realtà.» Ana guardò un punto oltre lo schermo. Poi ritornò su di me. «Lisandro oggi compie sei anni. Gli avevo promesso un gelato. Per questo sono venuta qui. È un bambino dolcissimo ma purtroppo è nato nella famiglia sbagliata. Suo fratello maggiore penso sia immischiato in qualche grosso traffico illegale. Non lo so. È una mia sensazione ma non credo di sbagliarmi. Per adesso sono riuscita a non farlo coinvolgere ma non è facile. Sto cercando di capire qualcosa in più; gli faccio domande ma lui non mi ha rivelato ancora nulla. Credo abbia paura a confidarsi. La scorsa settimana non si è presentato a nessun incontro in parrocchia e, quando sono andata a cercarlo, l’ho trovato a casa pieno di lividi sulle braccia e in faccia.»
Rabbrividii nel pensare un bambino in quelle condi- zioni. «Mamma mia… che brutta situazione.»
«Già. Vorrei poter almeno aiutare lui. Prima che sia troppo tardi.»
Una manciata di sabbia andò sul viso di Ana. Qual- cuno aveva corso a pochi passi da lei. Sembrò non farci caso, ancora concentrata a pensare a Lisandro. Io sicu- ramente avrei detto qualcosa di poco gentile.
Ritornò a guardare oltre lo schermo. Chiuse leggermente gli occhi come per mettere meglio a fuoco. Questa volta sorrise. Presunsi che il bambino fosse arrivato.
Guardai l’ora. Mancavano pochi minuti alla fine della lezione. Potevamo salutarci.
Con il riverbero della calda luce solare ancora negli occhi, me ne andai da Rio pronta a tuffarmi tra le architetture rinascimentali fiorentine.
** *
«Siamo riusciti a sistemare due bambine in una famiglia d’appoggio. Non staranno lì per molto ma è già qualcosa.»
Ana mi diede la notizia ancora prima di salutarmi. Era euforica. Batteva le mani mentre parlava.
In quel nostro primo mese abbondante di conoscenza, avevo scoperto che persona sensibile e generosa fosse. In particolare con i bambini più bisognosi della sua città.
Adesso che mi aveva resa partecipe di quel problema che le stava molto a cuore, non parlava d’altro. A me andava bene. Era sempre un modo per farla parlare e aiutarla con la lingua.
D’altro canto, mi ero documentata un po’ per non perdermi pezzi importanti di quanto mi diceva; non era la prima volta che lo facevo su qualche episodio che succedeva a un mio studente.
Dopo la videochiamata dell’ultima lezione, avevo googlato per fare più chiarezza sulla situazione che mi aveva descritto a Rio. Avevo scoperto che era peggiore di quello che inizialmente avevo pensato. Le favelas erano delle vere e proprie città nella città, con regole tutte loro, caratterizzate perlopiù da povere baracche. Non essendo riconosciute dallo Stato, i servizi base, come l’energia elettrica, l’acqua e le fognature, non erano garantiti.
I padroni di quelle città erano i narcotrafficanti che si contendevano il controllo della zona e cercavano di imporre le proprie regole alla popolazione. Spesso si scontravano duramente con la polizia che, per far rispettare l’ordine, non risparmiava pestaggi e arresti sommari.
Neanche i bambini purtroppo erano esentati da tutto questo. Spesso orfani o abbandonati dalle loro famiglie d’origine, sopravvivevano dedicandosi all’elemosina o esercitando attività illegali, spesso ingaggiati dalla malavita come corrieri della droga o killer su commissione. Era vero che sniffavano colla, per stordirsi e attutire lo stimolo della fame. Per sopravvivere si organizzavano in gruppi, frequentando luoghi di grande passaggio nelle zone più centrali e turistiche, in modo da avere maggiori possibilità di guadagnare qualcosa mediante rapine o furti. La loro aspettativa di vita era brevissima: pochi superavano i vent’anni.
Mi ero soffermata a leggere alcuni episodi di domi- nio pubblico successi anni prima, che però mi erano sfuggiti o non erano stati proprio riportati sui giorna- li inglesi per scarso interesse dell’opinione pubblica; uno tra tutti, la sparatoria avvenuta nel 1993 per mano della polizia dove avevano perso la vita molti di questi bambini davanti alla Chiesa di Candelária. Era stato terribile. Vergognoso il fatto che non se ne fosse parla- to. Anche la morte perde il suo pubblico se non ci sono interessi, avevo pensato disgustata.
«Sono contenta. Vedrai che grazie a questo non fini- ranno di nuovo in strada.»
«Speriamo. Si tratta di alcuni mesi ma spero che, stando vicino a gente normale, capiscano ciò che è giusto e sbagliato nella vita. Per loro, lo dico. Per la loro vita.»
«Certo, vedrai. I bambini sono come spugne. Imparano in fretta.»
Sono veloci anche a dimenticarsi, pensai. Ma questo non glielo dissi. Era giusto festeggiare quel piccolo traguardo. Non doveva essere stato facile ottenerlo.
«Com’è andato il pomeriggio con Lisandro? Gli è piaciuto il gelato?»
Mi guardò in maniera stupita. Poi si ricordò. «Ah sì, per il suo compleanno. No, alla fine non lo abbiamo preso.»
Girò lo sguardo in basso. Conoscevo ormai quel suo modo di fare. Rimasi zitta in attesa che continuasse. E infatti non mi lasciò il tempo di ribattere e continuò il corso dei suoi pensieri.
«Io non gli credo, sai? Mi ha detto che non aveva fame perché aveva appena mangiato. Io penso proprio che abbia iniziato ad annusare la colla. E credo sia stato il fratello a dirgli di farlo. Quando gli ho detto che l’avrei accompagnato volentieri a casa, si è svincolato dal mio abbraccio ed è corso via. Non l’aveva mai fatto. Prima voleva sempre che lo portassi fin davanti alla baracca dove vive e mi facessi vedere dalla madre; aveva paura lo picchiasse per non essere stato con lei ad aiutarla in qualche faccenda. Ho paura sia caduto in qualche attività poco sicura. In parrocchia non si fa più vedere molto. Sono alcuni giorni che è sparito. Inizio a preoccuparmi.»
La felicità che mi aveva mostrato qualche minuto prima si era volatilizzata di colpo come bolle di sapo- ne in mezzo a una tempesta. Non volevo causarle dolore. Non avevo minimamente pensato a questa piega degli eventi.
«Beh dai, non pensare subito male. Visto che era il suo compleanno magari aveva mangiato davvero di più ed era pieno. Magari qualche anima dolce e gentile come la tua gli aveva già offerto un dolce, forse qualcuno della parrocchia. E, sentendosi più grande, sarà voluto tornare a casa da solo. I bambini sono così.»
In realtà non sapevo come fossero i bambini visto che non li frequentavo molto e non avevo figli, ma era stato semplice concludere in quel modo. Gli unici bambini che potevo dire di aver “frequentato” erano i miei nipoti, figli dei miei fratelli, che vedevo pressoché solo alle feste comandate e ai compleanni. Ormai i miei fratelli ed io, con la morte di entrambi i genitori, ci vedevamo veramente poco. Non avevamo litigato né custodivamo brutti ricordi dell’infanzia, anzi ap- pena ci trovavamo sembrava non fosse passata più di un’ora dal nostro ultimo incontro. Eravamo solo tutti presi dalle nostre vite frenetiche e preferivamo gestire i rapporti così. Non avremmo pensato due volte ad aiutarci in caso di necessità e bisogno ma, nella normale quotidianità, vivevamo le nostre vite indipendentemente dagli altri.
Eravamo molti diversi, anzi ero io a essere molto di- versa da loro. Ero l’unica a non aver avuto figli, per scelta; l’unica ad aver continuato a viaggiare una volta raggiunta la maggiore età; l’unica a non frequentare più la Chiesa; l’unica a vivere una vita “fuori dalle regole”, come dicevano sempre loro.
Peter mi sgridava per il mio assenteismo dalle vite dei miei fratelli, ma era comunque contento fossi diversa.
Non so nemmeno perché non avessimo voluto generare una prole. Ci piacevano i bambini, non eravamo come quelle persone che, non sapendo come compor- tarsi davanti a un poppante, dicevano di non sopportarli, per nascondere l’imbarazzo o l’incapacità nel gestirli.
Forse stavamo bene così. Lui ed io. E basta.
Adesso che ero rimasta sola non sentivo nessun vuoto, nessun rimpianto, al contrario di quanto mi aveva predetto mia madre rinfacciandomi, fino a quando aveva potuto, quella nostra scelta.
Era proprio vero che ognuno trovava la propria strada con diverse scelte e metodi. La felicità era qualcosa di assolutamente personale e soggettivo. L’avevo capi- to dopo i quarant’anni quando avevo smesso di com- portarmi per compiacere agli altri.
«Non credo. Sento che c’è qualcosa sotto. Qualcosa di pericoloso.»
Ana disse l’ultima parola allungandone il suono. Come se, mentre la diceva, le fosse venuto in mente qualcosa.
«Pericoloso? Perché dici questo?»
«Non so. Ho una strana sensazione. Ma, ora che ci penso, ultimamente ho visto in giro spesso il fratello con un certo Bóris. Era un ragazzo delle favelas, spa- rito misteriosamente anni fa e ritornato con la scorta.»
«Con la scorta?»
«Sì. Qua si usa per indicare una persona molto ricca perché viaggia con uomini armati al suo fianco.»
«Beh, avrà avuto successo nel lavoro.»
Ana mi guardò come se fossi stupida.
«La scorta la usano poche persone. E tutte poco oneste. Se la vedi intorno a uno delle favelas significa solo una cosa: droga. Di quella internazionale.»
Strabuzzai gli occhi. Ana era seria. Per lei i giri dei narcotrafficanti erano roba reale. Grave. Per me erano ottimi protagonisti di qualche serie televisiva su Netflix. Mi sembrava tutto così irreale! Tutto lontano anni luce.
«Ne sei sicura?»
«No. Nessuno mi dirà mai cosa fa Bóris nella realtà. O il fratello di Lisandro. O Lisandro stesso. So solo che qualcosa sta cambiando e non in positivo. Temo per la vita di molte persone innocenti, soprattutto bambini.»
La questione stava diventando molto più seria. Là le persone perdevano la vita per davvero.
Mi venne un brivido lungo la schiena. Ebbi una brut- ta sensazione che mi fece, per un attimo, sentire freddo. Mi toccai le braccia prima di continuare a parlare. Mi sentivo scossa. «Allora, se queste persone sono così pericolose, è meglio lasciarle stare.»
Parole codarde. Ma sagge. Furono gli unici pensieri che riuscii a formulare ad alta voce. Li pensavo sul serio.
«Non posso. Non posso andarmene via sapendo che i ragazzi che stiamo aiutando sono in pericolo. È strano da spiegare ma mi sento responsabile per loro. Nessuno se ne prende cura. Qualcuno lo dovrà pur fare. E comunque voglio capire che fine ha fatto Lisandro.»
La capivo. «E cosa pensi di fare?»
«Andrò a parlare con suo fratello.»
«Direttamente con lui? Ma non è immischiato in quei traffici illegali? Non penso sia saggio. Sarebbe meglio che tu non ci andassi.»
Le urlai quasi addosso. Non ero sua madre, sua sorella o la sua migliore amica. Ero solo un’insegnante di inglese, pagata per parlarle due ore al giorno e aiutarla a migliorare la lingua.
Mi zittii troppo tardi. Ormai avevo parlato. Avevo oltrepassato il limite invisibile della privacy e del buon- senso. Il dogma numero uno del mio insegnamento era stato rotto. Mi vergognai immediatamente del mio comportamento, umano e sincero ma inopportuno. Mi aspettai una sua rimostranza. Una meritata sgridata.
Ana però non era Jameela e non era nemmeno il marito. Apparteneva a un altro genere di persone, più simile a me.
Capì infatti le mie intenzioni e le apprezzò. Mi sorrise con dolcezza, non solo con la bocca ma anche con gli occhi. «Devo farlo. Devo andarci di persona. Stai tranquilla, non succederà nulla.»
«Ne sei sicura?»
«Ma certo. Andrò a parlarci appena sarà da solo. Non mi farà niente, mi conosce. Voglio solo parlargli per sapere. Non faccio niente di male.»
La sua calma e tranquillità mi confortarono. L’ansia sparì. «Beh, se sei convinta, allora sarà la scelta giusta; sei tu che conosci quelle persone. Sei davvero una cara ragazza, Ana. Se ci fossero più donne come te, il mondo sarebbe perfetto, privo di problemi.» Lo pensavo davvero.
Nell’ultima parte della lezione parlammo d’altro. Volle sapere i luoghi più particolari da visitare una volta arrivata a Londra. Ci accordammo che avremmo fatto lezione ogni giorno in un posto nuovo: su una panchina a Hyde Park, sedute a un tavolino di Covent Garden, sorseggiando una birra guardando la città dallo Skygarden, o gustando pesce crudo al trentottesimo piano del Sushisamba o mentre passeggiavamo tra le vie trafficate del centro e nei lunghi corridoi dei musei.
Si era già innamorata della mia città prima ancora di essere arrivata. Sapevo che non avrebbe avuto pro- blemi ad ambientarsi; era una che imparava in fretta e si sapeva adattare. L’avevo constatato in poco più di un mese di lezione. Il suo livello e la sua sicurezza nel parlare erano nettamente migliorati.
Le lasciai degli esercizi da fare per la sera, su alcune pronunce da migliorare. Ci salutammo con calore. Come sempre. Felici di tutti i discorsi fatti e pronte a ricominciarne di nuovi il giorno dopo.
Senza sapere che quella sarebbe stata la nostra ultima lezione.
Iscriviti
Inserisci la tua e-mail di seguito per ricevere gli aggiornamenti.